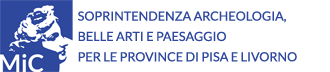- Archeologia preventiva
- Concessioni di scavo e ricerche archeologiche
- Reperti archeologici in possesso di privati
- Tutela paleontologica
- Carta archeologica
Archeologia preventiva
Il Codice degli appalti (d.lgs. 163/2006, artt. 95-97) ha introdotto nella normativa italiana l’archeologia preventiva, ossia l’insieme di procedure necessarie a garantire una valutazione preliminare del rischio di interferenze con strutture e depositi di interesse archeologico.
Il regolamento attuativo è stato definito con il d.m. 60/2009
Nel Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 50/2016, i riferimenti all’archeologia preventiva sono confluiti all’art. 25.
Per approfondimenti sui requisiti degli archeologi che possono svolgere le attività di archeologia preventiva, visita il portale Professionisti dei beni culturali.
Concessioni di scavo e ricerche archeologiche
Le attività di ricerca archeologica sul territorio sono riservate al Ministero della Cultura, che può svolgerle direttamente oppure affidarle in concessione ad altri soggetti pubblici o privati (artt. 88 e 89 del Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Per le modalità procedurali e le restrizioni relative alle concessioni di ricerca con particolare attenzione alle attività di scavo o di ricognizione superficiale in aree non demaniali e al premio di rinvenimento (art. 92 del Codice), si rimanda alle circolari n. 24/2012 della Direzione generale per i beni archeologici, n. 8/2013 della Direzione generale per le antichità, nn. 3/2015 e 6/2016 della Direzione generale archeologia, e alle disposizioni nn. 21/2016, 17/2018, 37/2018, 4/2019, 7/2019 e 30/2019 emanate dalla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio.
Ulteriori precisazioni procedurali sono fornite dalle circolari nn. 14/2021 e 37/2021 della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio.
Più in generale, per le norme che regolano il settore, si vedano la circolare n. 94/2000 dell’Ufficio centrale per i beni ambientali, archeologici, artistici e storici e le note prott. 14184 del 30/09/2004 e 958 del 04/10/2005 della Direzione generale per i beni archeologici.
Per ulteriori informazioni sulle modalità operative, sulla normativa e sulla modulistica aggiornata, consultare il sito dell’Istituto Centrale per l’Archeologia.
Responsabile: Arianna Vernillo
055-2651894 / arianna.vernillo@beniculturali.it
Reperti archeologici in possesso di privati
Tra le attività svolte dalla Soprintendenza, relative alla tutela del patrimonio archeologico, assume particolare rilievo quella del riscontro e della verifica di autenticità dei reperti archeologici dichiarati da privati.
Quelle che seguono sono le indicazioni utili a chiarire l’iter procedurale per la detenzione di reperti archeologici non accompagnati da fattura di acquisto e non derivanti da premi di rinvenimento ai sensi dell’art. 92 del Codice.
1 – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (scaricabile nella sezione Modulistica), da inviare alla Soprintendenza per mail (PEO: sabap-fi@beniculturali.it oppure PEC: mbac-sabap-fi@mailcert.beniculturali.it), debitamente sottoscritta e corredata da un documento di identità valido e una documentazione fotografica di massima dei reperti. Nella dichiarazione si chiede di inserire tutte le informazioni utili ai fini del perfezionamento dell’istruttoria (ad esempio eventi che hanno portato al possesso dei reperti, numero dei reperti, verosimile provenienza ecc.).
2 – Sopralluogo, concordato per le vie brevi, da parte di un funzionario archeologo della Soprintendenza, al fine di riscontrare i reperti dichiarati, verificarne l’autenticità e documentarli (misure e riprese fotografiche).
3 – Invio della documentazione raccolta da parte della Soprintendenza al Nucleo Carabinieri del Patrimonio Culturale per gli accertamenti di competenza sui reperti segnalati.
4 – A conclusione degli accertamenti, in caso in cui il Nucleo non abbia rilevato la presenza di illeciti, inoltro al dichiarante degli esiti, con presa d’atto che i reperti restano nella disponibilità dello stesso, fatta salva la possibilità di avvio del procedimento di dichiarazione di interesse secondo le norme vigenti. In caso in cui, invece, siano stati rilevati illeciti, le comunicazioni verranno inoltrate direttamente dal Nucleo Tutela.
Responsabile: Michele Bueno
055-2651831 / michele.bueno@beniculturali.it
Tutela paleontologica
Il territorio italiano, per gran parte costituito da rocce sedimentarie, è caratterizzato da una vasta diffusione di reperti fossili, nella fattispecie faune di vertebrati e invertebrati, vegetali e impronte o tracce fossili. Al pari dei beni culturali, anche “cose che interessano la paleontologia” sono tutelate dal Codice.
Il servizio Tutela paleontologica della Soprintendenza si occupa delle questioni generali inerenti ai beni paleontologici, intesi sia come beni mobili (reperti fossili) che immobili (giacimenti paleontologici e sezioni stratigrafiche). Nell’ambito delle problematiche sopra-territoriali concernenti la paleontologia, il servizio è il referente per gli uffici centrali del Ministero, per i referenti regionali per la paleontologia, per gli istituti di ricerca e per altri enti del settore.
Su richiesta, il servizio fornisce supporto ai funzionari archeologi nelle attività legate a rinvenimenti di fossili e recuperi, schedature, vincoli, sequestri e confische, esposizione e valorizzazione di beni paleontologici.
Responsabile: Ursula Wierer (archeologo)
055-2651741 / ursula.wierer@beniculturali.it
Carta archeologica
Il servizio di Carta Archeologica si occupa della ricezione, redazione, normalizzazione e sistematizzazione dei dati cartografici relativi ai rinvenimenti che avvengono sui territori di competenza della Soprintendenza.
La base informativa attualmente in uso è costituita da dataset in formato shapefile puntuale e, ove disponibili, poligonale, posizionati utilizzando la proiezione Gauss-Boaga e avendo come base cartografica la Carta Tecnica Regionale Toscana in scala 1:10.000.
Il servizio costituisce una base indispensabile per il fondamentale lavoro di individuazione e tutela dei beni archeologici disseminati sul territorio, e si integra attraverso i servizi WMS di Regione Toscana con le cartografie relative ai vincoli archeologici e alle zone di interesse archeologico (vincoli ai sensi dell’art. 142, c. 1, lett. m del Codice). La gestione del dato avviene per il momento attraverso client-GIS Q-Gis (v. 3.4 e successive).
È tuttavia in corso, attraverso una collaborazione con Università di Pisa, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno, Regione Toscana, l’elaborazione di una piattaforma web-GIS in grado di consentire la gestione più immediata del dato in ingresso, consentendo operazioni di data-entry che permetteranno la rapida implementazione del sistema, la visualizzazione e interrogazione del Geo-DB per uso interno e la messa a disposizione all’utenza esterna di layer cartografici WMS.
Il progetto, denominato MAGOH (Managing Archaeological data for a sustainable GOvernance of the Heritage), si concluderà entro la fine del 2022, con la messa on-line della piattaforma. Maggiori dettagli al link: www.mappalab.eu/magoh/
Responsabile: Pierluigi Giroldini
055-2651846 / pierluigi.giroldini@beniculturali.it